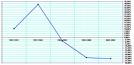
Il Prodotto Interno Lordo è un indicatore in crisi da alcuni decenni. Questo, almeno nelle scienze sociali. Meno nel dibattito pubblico e nelle decisioni politiche. I suoi saliscendi mettono in crisi i governi e fanno fibrillare le borse.
Ma non sempre meno PIL significa meno benessere, o, viceversa, più PIL equivale a più progresso. Abbiamo bisogno di nuovi indicatori e, nell’attesa, di saper leggere in maniera critica l’andamento dell’indicatore più famoso del ventesimo secolo. Ma, forse, non del ventunesimo.
Il PIL e il suo successo
Il PIL (Prodotto Interno Lordo), è la somma calcolata al valore di mercato di tutti i beni e i servizi prodotti in un paese in un determinato periodo di tempo, generalmente un anno. Rapportato alla popolazione (PIL pro-capite), consente comparazioni nel tempo e nello spazio di differenti paesi, regioni o altre unità sub-nazionali, quando l’indicatore sia disponibile per questi aggregati territoriali.
Il PIL è probabilmente lo strumento di maggiore successo mai sviluppato dalle scienze sociali. Esso combina sofisticate caratteristiche teoriche e utilità pratica in modo che nessuna altra misura nemmeno lontanamente riesce a dare.
Non a caso, è generalmente il primo indicatore che viene utilizzato nella diagnosi di una situazione economica e sociale e nella comparazione tra contesti diversi. Sotto forma di tasso di crescita (del PIL), esercita una vera e propria dittatura mediatica nelle valutazioni e nei dibattiti delle performances nel tempo di un paese o di una regione.
Critiche al PIL: la "depilizzazione" del progresso
Nonostante il larghissimo uso, il concetto stesso di PIL è stato sottoposto, fin dalla sua messa a punto (negli anni a cavallo della seconda guerra mondiale), a numerose e profonde critiche che, negli ultimi anni sono fortemente cresciute fino a reclamare una “depilizzazione” degli indicatori di progresso economico e sociale. In maniera sintetica e schematica, le principali di tali critiche sono le seguenti: – in primo luogo, il PIL sovrastima in modo marcato la ricchezza disponibile perché conteggia come “beni” prodotti e consumati cose che in realtà sono “costi” per la collettività, come le ingenti spese di carburante nelle congestioni del traffico, come le spese per la sicurezza per contrastare il crimine, le spese per gli armamenti, eccetera. Si assiste perciò al paradosso per cui una diminuzione di incidenti stradali, una riduzione del numero dei furti e delle rapine, un miglioramento della salute, determinerebbero un abbassamento significativo del PIL, dunque una crisi. Inoltre, non conteggia il consumo irreversibile di ambiente che si produce con una crescita dissennata, per uscire dalla quale magari si avvia un grande programma di bonifiche ambientali – che figurerà come “produzione” di beni e servizi – per compensare inquinamenti mai considerati dal lato dei costi. Si potrebbe insomma dire che si tratta di un vero e proprio falso in bilancio: la crescita economica continua e senza limiti (che è meramente una crescita di aggregati contabili falsi – poiché mancano i costi correttamente imputati) ha sempre meno relazione con il benessere delle persone e della società. – in secondo luogo, il PIL rischia di sottovalutare la ricchezza effettivamente disponibile. Infatti, sommando i beni e i servizi scambiati sul mercato, il PIL esclude tutte quelle “produzioni” e dunque quella ricchezza che non passa per il mercato, come ciò che deriva dal lavoro domestico in senso lato (dalla casalinga al fai-da-te), dalla produzione di autoconsumo del mondo rurale, dai servizi di vicinato o di comunità su una base di reciprocità, insomma tutta una “economia” in senso proprio, che le statistiche non vogliono o meglio non possono (ancora) misurare. La forzatura che l’indicatore PIL opera sulla realtà (peraltro inevitabile nel caso degli indicatori) è identica a quella che definisce la popolazione attiva e gli altri aggregati del mercato del lavoro: secondo un paradosso molto citato, se io ho una governante il suo lavoro e il suo stipendio entrano nel calcolo del PIL, ma se la sposo, la mia governante, determino un abbassamento del PIL perché, in quanto casalinga, non è attiva e il lavoro che continua a fare non è computato nella contabilità nazionale. Ma soprattutto, la sottovalutazione della produzione e della ricchezza effettive riguarda la non considerazione della economia “sommersa”. Questa costituisce, anche nei paesi industrializzati, una realtà consistente e apparentemente in crescita negli ultimi decenni. In Italia, studi e ricerche nonché la stessa ISTAT stimano che un quinto circa della economia reale (con punte decisamente superiori nel Mezzogiorno) sia occulta. Nelle realtà in via di sviluppo, la percentuale di sommerso costituisce in più di un caso la metà della economia reale. – In terzo luogo, il PIL, soprattutto nella sintetica forma del PIL pro-capite, non offre nessuna informazione sulla distribuzione, più o meno equa o ingiusta, tra le diverse fasce della popolazione: un aumento anche significativo può essere irrilevante per le categorie ai margini sociali ed economici di un paese/regione e, viceversa, una diminuzione può non tradursi in grandi disagi se spalmata in modo corretto sui diversi strati sociali. – Infine, il PIL ha fatto il suo tempo. Se infatti l’indicatore funzionava nelle fasi iniziali del processo di sviluppo di un paese, nel quale l’aumento degli scambi di mercato rilevata dallo stesso indicatore era il segno di un allargamento del mercato (la costruzione del mercato nazionale), la sua capacità di cogliere sviluppo e progresso è decisamente scemata nel tempo. Ora, nella migliore delle ipotesi, il PIL è una misura del benessere materiale, della quantità di beni e servizi a disposizione. In società fondamentalmente povere, nelle quali anche i bisogni più elementari faticavano ad essere soddisfatti per tutti, l’obiettivo dell’economia non poteva che essere quello di far crescere le risorse e assicurarne una equa e razionale distribuzione.
Il PIL e i limiti sociali della crescita
Ma l’impetuosa crescita economica del dopo-guerra ha finito per scontrarsi con i limiti “sociali” della crescita. Come aveva lucidamente argomentato Fred Hirsch nel 1972, esistono beni cosiddetti “posizionali” il cui consumo dipende dal consumo che ne fanno gli altri (o che non fanno). C’è innanzitutto un fenomeno di congestione fisica (affollamento): ad esempio, l’automobile è, in sé, un bene di consumo che fornisce evidentemente una certa utilità; ma, se uso l’automobile per giungere al lavoro, un aumento dell’uso dell’automobile da parte di altri renderà il percorso più lento, causando una perdita di utilità per me (e per tutti gli altri). Ma esiste anche un fenomeno di “congestione sociale”: se ci si iscrive all’università con la speranza di avere un lavoro meglio remunerato alla fine degli studi, l’apertura dell’università ad un maggior numero di iscritti diminuisce il valore “posizionale” del titolo di studio sul mercato del lavoro. Hirsch individuava come contraddizione nella società capitalistica occidentale moderna (già colta ad inizio Novecento da studiosi come Ortega y Gasset) la competizione “inutile e dannosa” per beni posizionali la cui disponibilità non può che essere limitata. Da qui, l’attenzione crescente, per uno sviluppo equilibrato e sostenibile, ai cosiddetti beni collettivi. Dei quali, peraltro, nel PIL non c’è traccia. Negli ultimi anni, l’insoddisfazione per il PIL, come per altri indicatori, è uscita dall’ambito accademico di studiosi più o meno radicali per investire opinioni pubbliche, governi e istituzioni internazionali. Nel 2007, la Commissione Europea ha lanciato con un grande seminario internazionale dal significativo titolo di Beyond GDP un più vasto programma di ricerca e di riflessione sulle “misure del progresso in un mondo che cambia”. Joseph Stiglitz, Amartya Sen e Jean-Paul Fitoussi, tre degli economisti più apprezzati di questi anni, hanno presieduto (Stiglitz) e animato una Commissione per la misura dei risultati economici e del progresso sociale, promossa dal presidente francese Sarkozy. I documenti che emergono dai lavori del convegno e dalla Commissione presieduta da Stiglitz concordano sulla necessità di “superare” il PIL. Indicatori statistici e democrazia Ma, soprattutto, queste due grandi occasioni di riflessione e dibattito hanno messo in evidenza una grande questione contemporanea. Sempre più frequentemente si registra infatti uno scarto consistente tra le misure tradizionali delle grandi variabili socio-economiche – come la crescita, l’inflazione, la disoccupazione, per esempio – e la percezione diffusa tra la gente di questi fenomeni. Come osserva il Rapporto della Commissione presieduta da Stiglitz, le misure ufficiali possono lasciar intendere che l’inflazione sia minore o che la crescita sia maggiore di quanto viene percepito dalle persone comuni. Questo scarto è così significativo e diffuso che non può essere spiegato facendo riferimento a una qualche “illusione monetaria” o ai caratteri della psicologia umana. Si tratta di un fenomeno che ha già pesantemente incrinato la fiducia nelle statistiche ufficiali. In Francia e in Gran Bretagna, ad esempio, meno di un terzo dei cittadini dichiara di credere ai numeri ufficiali. In Italia, pur in mancanza di sondaggi in proposito, crediamo si possa affermare che la situazione sia la stessa se non peggiore. Chi non ricorda il dibattito di qualche tempo fa sull’inflazione “percepita” e su quella “misurata”? E chi non osserva, quotidianamente, il discredito, quasi l’irrisione per le statistiche ufficiali dell’ISTAT provenire anche dalle alte sfere della politica e del governo, quasi che ciascuno sia autorizzato ad avere “altri dati” da utilizzare strumentalmente per sostenere le proprie tesi? Un fenomeno di questo genere è fortemente negativo, perché impedisce un dibattito serio e sereno su dati che dovrebbero essere oggettivi, patrimonio di tutti, e alimenta l’esplosione di suggestioni individuali che non portano da nessuna parte o meglio conducono in un territorio ambiguo e pericoloso per la democrazia. Il decisore politico, chiunque esso sia, si sgancia in questo modo da qualunque verifica sulle scelte operate e ottiene il consenso solo per un’adesione fideistica alle proprie posizioni di potere. Il cittadino informato e cosciente rappresenta, come noto, una condizione di base per il funzionamento della democrazia. D’altra parte, se gli indicatori statistici sono importanti per concepire e per valutare le politiche, ma anche per “governare” le varie dimensioni della vita sociale ed economica, ciò che si misura e il modo con il quale si misura è di grande rilevanza, poiché, evidentemente, se le misure sono carenti per una ragione o per l’altra, ne conseguono decisioni politiche e valutazioni della situazione altrettanto carenti. In altri termini, ciò che è in discussione non è il PIL in quanto tale, quanto ciò che si vuole fargli dire: per tante ragioni, tra cui quelle viste in precedenza, esso non è adeguato a misurare correttamente il benessere economico, né, tanto meno il benessere sociale o il benessere tout court. Per inciso, si può largamente concordare con Stiglitz quando osserva che una delle ragioni per le quali la crisi finanziaria internazionale del 2008 ha preso alla sprovvista governi e istituzioni è che non sono stati presi in esame “buoni” indicatori statistici (come quelli relativi, ad esempio, alla consistenza dei beni patrimoniali delle imprese o all’indebitamento privato) e che il sistema di misura fondato sul Pil ha fatto clamorosamente cilecca, proprio perché è strutturalmente limitato a considerare beni e servizi scambiati, senza poter capire se la crescita degli scambi e dei profitti fosse legata, come è stato, a una bolla speculativa destinata ad esplodere. Misure alternative al Pil Da tempo, come s’è detto, il Pil è oggetto di critiche anche feroci. D’altro lato, l’inarrestabile crescita dei beni e dei servizi a disposizione – che dura da due secoli – ha prodotto una specie di nausea, come ha scritto Ruffolo, per cui i sondaggi sul grado di “felicità” delle persone mostrano un crescente divario tra la curva del PIL e quella appunto della “felicità”. La differenziazione dei bisogni, delle preferenze, dei costi, tipica di società ormai molto complesse come quelle occidentali, non può essere riflessa adeguatamente da un indicatore che ci dice soltanto quanti beni sono stati prodotti e scambiati nel mercato. Non trovo che il riferimento alla “felicità” sia una fuga in avanti. Prima di diventare una “scienza triste” (the dismal science come la definì Carlyle), l’economia politica era definita (da Genovesi e da Verri, in Italia) come la “scienza della pubblica felicità”. D’altronde, privilegiare la crescita del numero dei beni di consumo materiale non può giustificarsi, in ultima analisi, che per quello che questi beni apportano alla qualità della vita degli esseri umani, direttamente o indirettamente. In sostanza, al loro benessere, alla loro felicità.
Le nuove misure del benessere
Da almeno trent’anni, soprattutto in conseguenza dell’emergere della questione ambientale (il classico The Limits to Growth è uscito nel 1972), vi sono state numerosi nuovi indicatori proposti per sostituire (o per integrare) il PIL. Per limitarci ai più noti, nel 1972, Nordhaus e Tobin hanno proposto il MEW (Measure of Economic Welfare), che sottraeva dal PIL tradizionalmente calcolato alcuni costi relativi a “negatività” dal reddito nazionale totale, come ad esempio l’inquinamento, escludeva dal calcolo alcuni servizi, come ad esempio quelli di polizia (giudicando che l’aumento di spese per l’apparato anticrimine non rappresenti affatto un miglioramento del benessere) e, infine, aggiungeva al PIL alcune attività altrimenti non considerate, come il lavoro domestico e il tempo libero. Successivamente (Daly e Cobb, 1989 e Cobb e Cobb, 1994) sono stati proposti l’ISEW (Index of Sustainable Economic Welfare) e il GPI (Genuine Progress Indicator). Il primo introduce nella misura della ricchezza nazionale correzioni analoghe a quelle proposte nel MEW. Il GPI, invece, collegandosi alle teorie più radicali che andavano proponendo un sentiero di “decrescita” ecologicamente compatibile, ha sviluppato metodologie totalmente differenti e alternative al PIL. L’indicatore genuino di progresso ha rapidamente conquistato seguaci che animano internazionalmente gruppi di lavoro che ri-calcolano la vera ricchezza nazionale in diversi paesi (come Usa, Germania, Svezia, Australia, Canada). In particolare, il GPI calcolato per gli Stati Uniti dal 1955, mostra che, contrariamente all’idea di un progresso continuo che il tasso di crescita del PIL pro-capite accrediterebbe, la qualità della vita – negli USA – è in continuo peggioramento. Le stime condotte con metodologie simili in altri paesi confermerebbero questa tendenza. Non mancano, naturalmente, proposte bizzarre, ancorché simpaticamente provocatorie. Il Bhutan ha infatti ufficialmente adottato come misura del progresso economico la FIL, Felicità interna lorda: come sostiene il Dalai Lama, convinto sostenitore della FIL, felicità non è solamente il piacere effimero che deriva dai piaceri materiali, ma è quella che si raggiunge da una completa trasformazione della mente e che può essere ottenuta coltivando la compassione, la pazienza e la saggezza, per cui il fine dello sviluppo economico dovrebbe essere quello di non ostacolare il raggiungimento della felicità. Altri indicatori che hanno conosciuto una larga diffusione dagli anni Novanta, e che diamo per noti, sono l’Indice di Sviluppo Umano (Human Development Index), la cosiddetta impronta ecologica (Ecological Footprint) e, più recentemente il tasso netto di risparmio (Adjusted Net Saving). Tuttavia, se è vero che monta l’insoddisfazione verso l’ormai obsoleto PIL, bisogna pur dire che un’alternativa capace di sostituirlo in maniera soddisfacente non sembra ancora disponibile. Da un lato, infatti, non possiamo dimenticare che, ancora oggi, esiste una significativa correlazione tra il PIL e gli altri indicatori che privilegiano aspetti più “sociali” quali la speranza di vita, l’alfabetismo, la mortalità infantile, eccetera. D’altra parte, con tutte le sue contraddizioni e limiti il PIL si basa sul computo di valori oggettivi quali sono i prezzi di mercato, mentre altre pur suggestive “grandezze”, quali il benessere, la felicità, la soddisfazione, eccetera, risultano di complessa o addirittura impossibile misurazione. Non vorremmo in sostanza che fosse il re del Bhutan o qualche politico nostrano unto dal Signore a dirci se stiamo progredendo oppure no.
Una lettura consapevole dell’andamento del PIL
Il dibattito sul PIL, ad ogni modo, ci consegna spazi enormi di riflessione e di ricerca. In primis, il Pil va sempre integrato (questa è la principale raccomandazione del Convegno europeo Beyond GDP e della Commissione sopra ricordata) con indicatori che siano capaci di valutare anche gli aspetti del benessere sociale, della equa ripartizione dei redditi e della sostenibilità ambientale. Nonché, last but not least, di leggere in modo più corretto gli stessi fenomeni economici. In secondo luogo, ci spinge a sviluppare un’analisi critica del dato statistico, della sua rilevazione e della sua formazione, per evitare che – al di là della correttezza tecnica del calcolo – si sostengano, per pigrizia o per incompetenza, tesi e verità non aderenti a ciò che l’indicatore utilizzato dice veramente. In sostanza, che il Pil diminuisca o aumenti, non sempre è un male né sempre è un bene.











